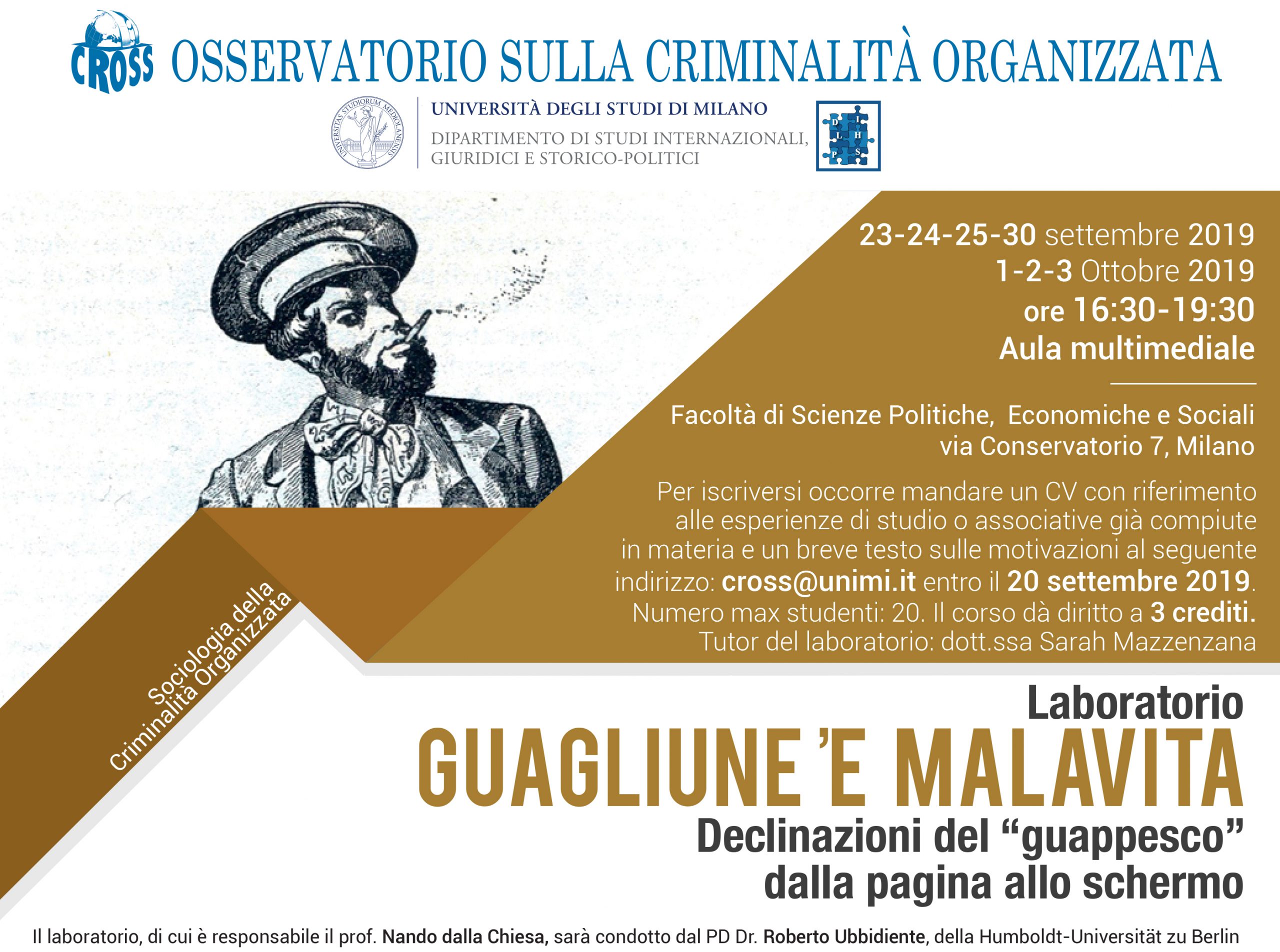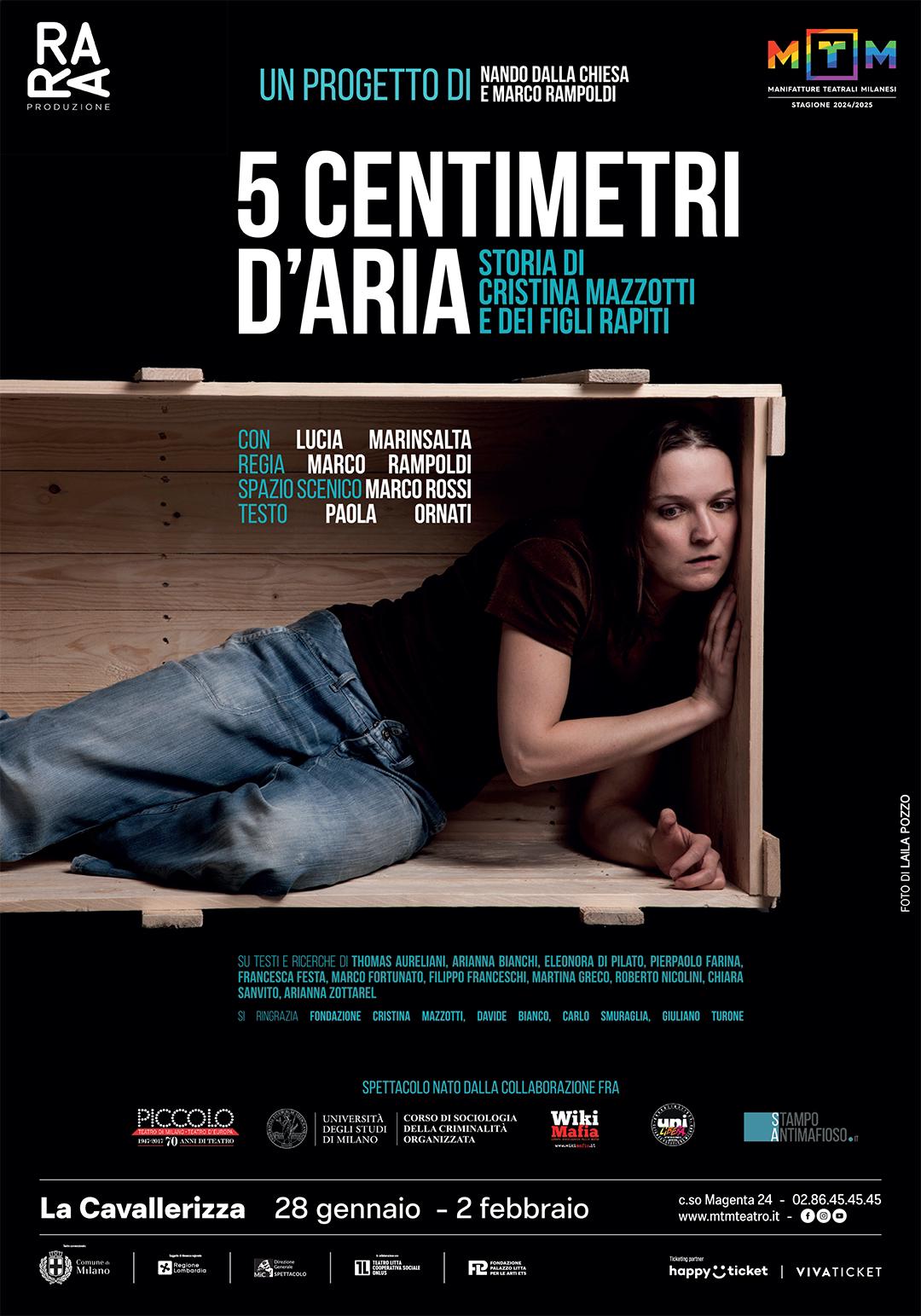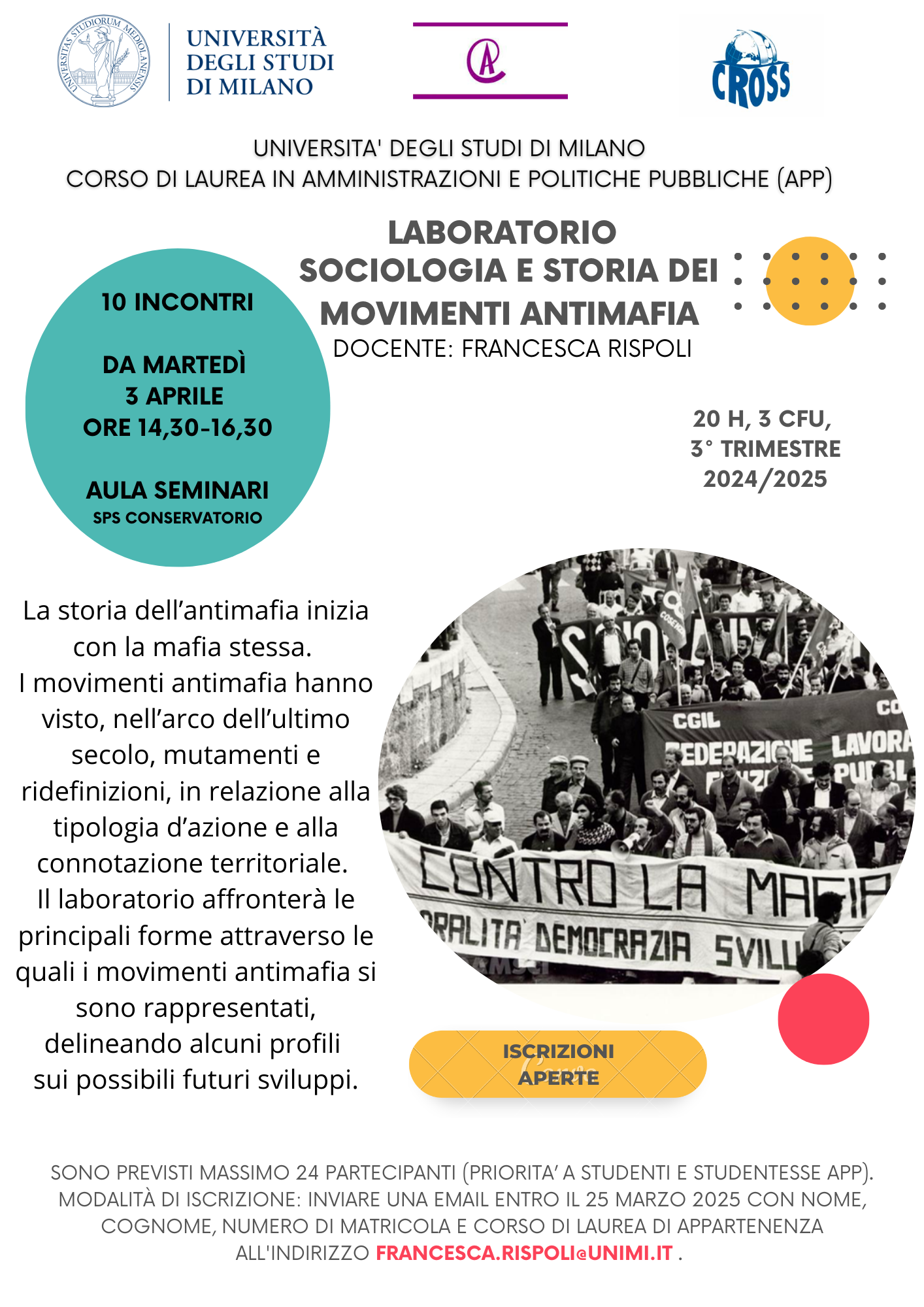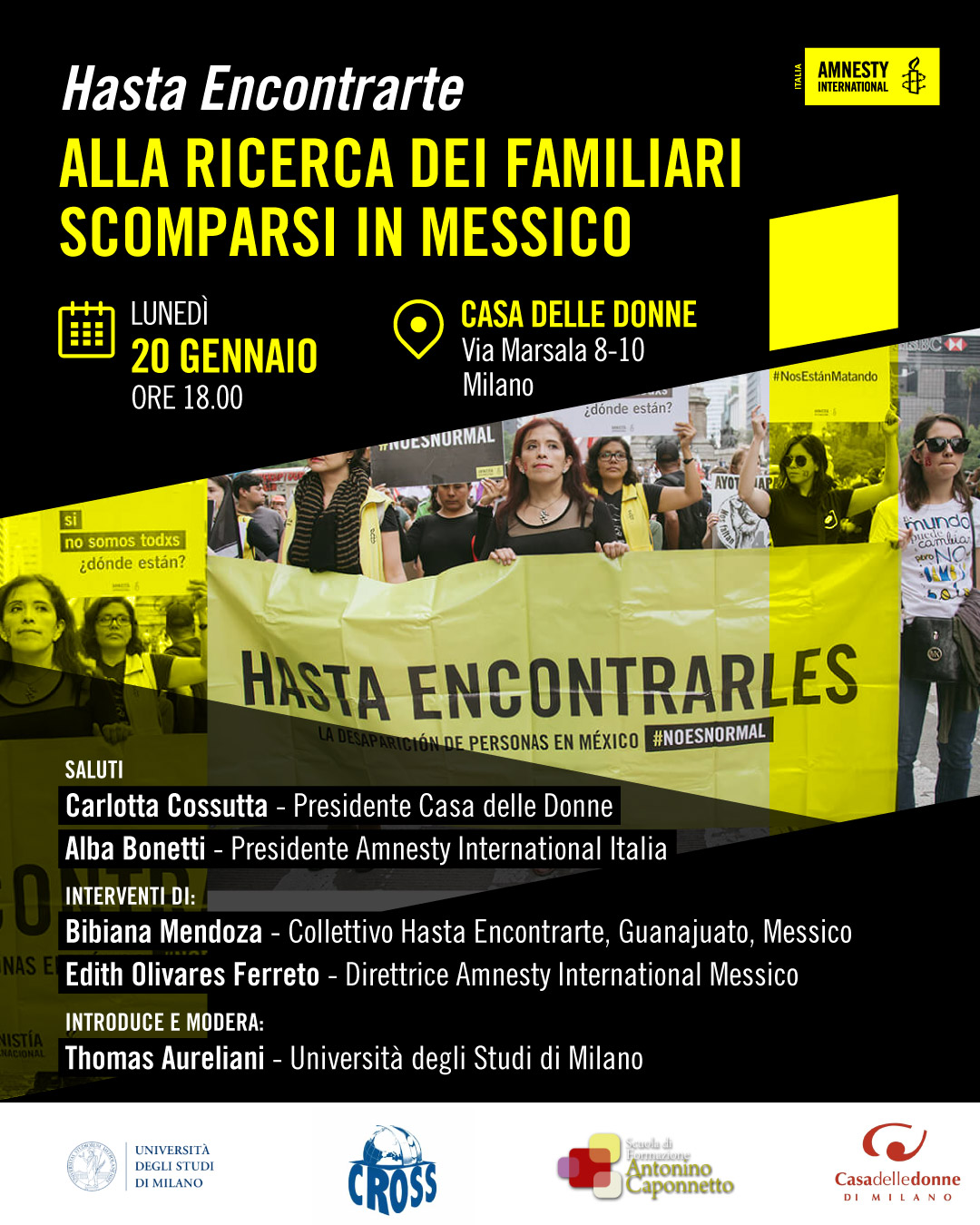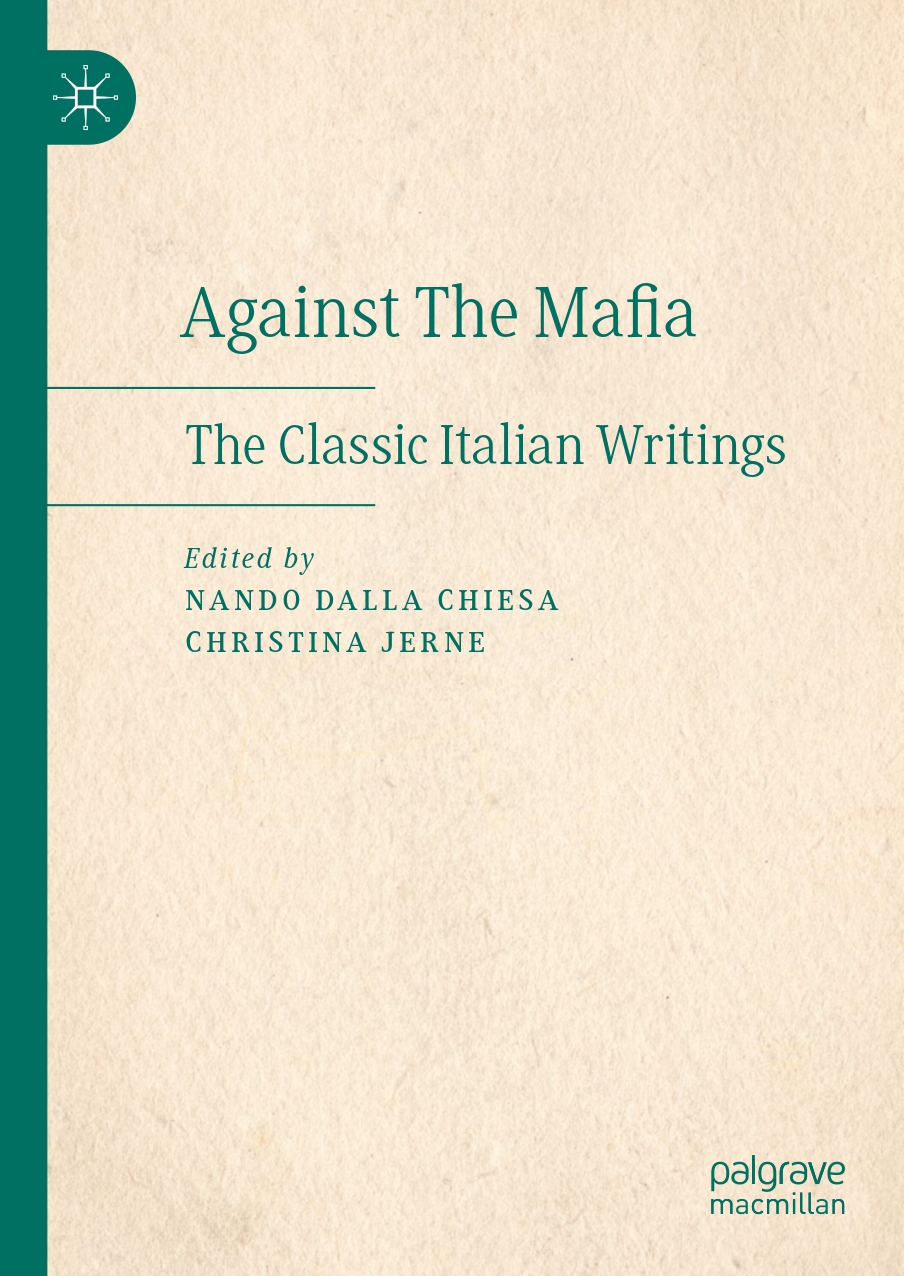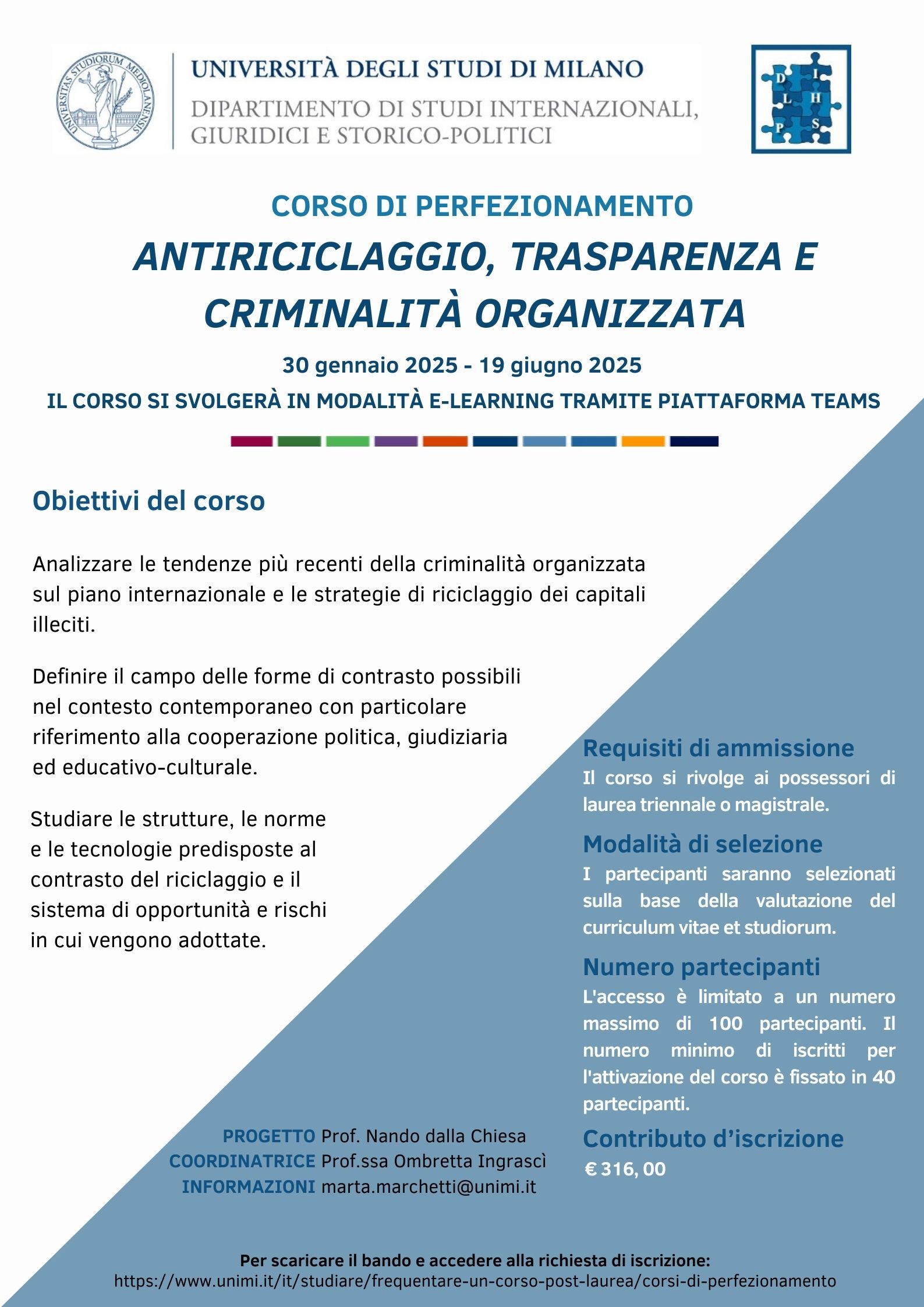Il laboratorio di studi culturali che qui si propone trova il suo movens nella convinzione che il tema della cultura popolare sia stato finora scarsamente considerato nelle ricerche sulla camorra e che, al contrario, esso meriti maggiore considerazione da parte degli “addetti ai lavori”. Difatti, lo studio delle dinamiche e degli strumenti che hanno portato alla formazione dell’immaginario collettivo di decine di migliaia di napoletani che — soprattutto nelle periferie di recente formazione — vivono quotidianamente a contatto con il fenomeno camorristico nelle sue più disparate manifestazioni, è in grado di fornire un contributo prezioso quanto inedito alla comprensione di ’O Sistema (Saviano; Ravveduto) dal punto di vista sociologico e culturale.
Se è vero che larghi strati della società partenopea sono arrivati ormai a considerare la camorra come una presenza costante e inevitabile della loro vita quotidiana, è anche vero che tale opinione si è cristallizzata lentamente nel tempo, anche attraverso prodotti culturali di larghissimo consumo che, specialmente nel vastissimo hinterland napoletano, hanno finito per alimentare nella memoria collettiva una narrazione distorta — dai tratti spesso celebrativi — delle “res gesta” camorristiche e dei loro protagonisti.
La cultura popolare partenopea offre, pertanto, numerosi e svariati esempi di messinscena e rappresentazioni fizionali del “camorristico” — inteso come categoria socio-culturale — nelle sue disparate incarnazioni: dai guappi e seguaci dell’ottocentesca Suggità fino agli “abitanti” della moderna Gomorra e ai capoclan alla guida del Sistema, gli “attori” del crimine organizzato partenopeo hanno trovato posto non soltanto nelle pagine della coeva cronaca nera o nella saggistica criminologica e sociologica, ma sono stati anche oggetto di rappresentazioni e messinscene che hanno finito per dar vita ad un vero e proprio genere fizionale caratterizzato da una spiccata intermedialità. Che si tratti di un testo letterario (Serao, Mastriani), drammatico (Di Giacomo, Viviani, De Filippo) o canoro (Bovio, “canzone di giacca”), che si tratti di un genere cinematografico (Merola, Mauro), del teatro popolare (macchietta, sceneggiata) o di un sottogenere della canzone neomelodica, la cultura popolare napoletana offre una miriade di esempi e testimonianze di simili prodotti culturali, che solo una frettolosa indagine sociologica può stigmatizzare come poco rilevanti manifestazioni del “colore locale”. In realtà, come sanno da tempo gli studiosi, tali prodotti della cultura popolare si rivolgono ad un bacino di utenza che, tra Napoli e “provincia”, conta diversi milioni di persone e che ha il suo peso nella formazione dell’immaginario di un’intera collettività, con rilevanti ripercussioni di natura imagologica. Sulla base delle ricerche condotte da studiosi contemporanei, come per es. Marcello Ravveduto e Francesco Barbagallo, il laboratorio indagherà le declinazioni e le messinscene del “guappesco” e del camorristico nello specifico del “testo” filmico, con particolare riferimento al genere cinematografico della MalaNapoli e della cinesceneggiata.
Alla disamina dei differenti materiali empirici (sostanzialmente documenti cinematografici e televisivi) si farà precedere — in un primo blocco di lezioni — uno studio propedeutico delle principali direttrici d’indagine che, muovendo dal concetto di traduzione intersemiotica (Eco), si soffermerà sull’analisi della multi- e transmedialità nelle sue principali implicazioni estetiche e culturali.
A questi incontri seguirà un secondo blocco di lezioni di carattere empirico che si concluderà con l’analisi e la discussione di materiali video “classici”, considerati in modo innovativo dal punto di vista dell’imagologia e dei Cultural Studies.
Le lezioni si terranno presso l’aula multimediale (Via Conservatorio, 7) dalle 16.30 alle 19.30.
Calendario e programma delle lezioni
Lunedì 23 settembre 2019
- Introduzione all’imagologia e fondamenti teorici.
- Dalla pagina allo schermo: questioni di traduzione intersemiotica
Martedì 24 settembre 2019
- Tra finzione e realtà: il guappo dalla scena allo schermo (con un excursus eduardiano).
- Dalla macchietta alla sceneggiata: messinscene del guappo nel teatro popolare.
Mercoledì 25 settembre 2019
- Archetipo “Padrino” e sue declinazioni “periferiche”: i film della MalaNapoli
- La cinesceneggiata e i suoi “attori”.
Lunedì 30 settembre 2019
- Declinazioni canore del “guappo” da Scugnizzi ai neomelodici.
Martedì 1 ottobre 2019
- Un esempio di “riuso favoloso” tra Basile e Gomorra.
Mercoledì 2 ottobre 2019
- E fuori Napoli? Il mito del “ladro gentiluomo” e le sue declinazioni filmiche tra Hollywood e Bollywood.
Giovedì 3 ottobre 2019
- Test finale
Il laboratorio si terrà in Aula multimediale presso l’Università degli Studi di Milano, via conservatorio 7.
Per iscriversi occorre mandare un CV con riferimento alle esperienze di studio o associative già compiute in materia e un breve testo sulle motivazioni al seguente indirizzo: cross@unimi.it entro il 20 settembre 2019. Numero max studenti: 20. Il corso dà diritto a 3 crediti. Tutor del laboratorio: dott.ssa Sarah Mazzenzana